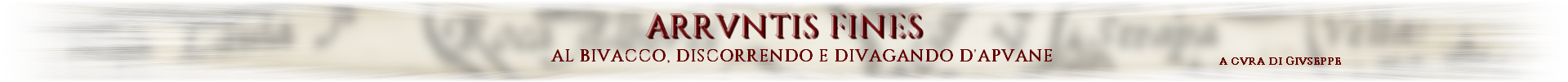
Nota iniziale: Si precisa che i nomi utilizzati in questa pagina sono fittizi. Qualsiasi riferimento a persone ed animali reali del luogo aventi i nomi utilizzati è puramente casuale ed involontario.
Vidi Antona per la prima volta nel 1955. Mio nonno materno era un pastore di quel paese, ma da quando aveva sposato mia nonna si era trasferito ad Avenza, frazione della quale lei era originaria e dove erano poi nate mia madre e le sue sorelle.
La famiglia era tornata ad Antona durante la guerra, per sfuggire ai bombardamenti alleati e lassù mio nonno era tornato alle sue capre, diventando così uno di quei pastori che, conoscendo benissimo quegli impervi luoghi aiutavano i fuggiaschi perseguitati dal nazismo e dal fascismo ad attraversare le linee tedesche schierate sulla linea gotica per raggiungere il territorio lucchese già liberato, in particolare il paese di Azzano, percorrendo quelli che adesso conosciamo come "i sentieri della libertà".![[...]Ho visto Antona per la prima volta nel 1955[...] Antona](PaesiApuaniIMG/Antona02.png)
Mio nonno sopravvisse alla guerra per altri dieci anni scarsi poi, ancor prima che io conoscessi il suo paese natìo, morì ucciso dai veleni dell'azienda avenzina in cui lavorava, la Rumianca. Abitavamo, allora, tutti insieme in una casa che la mia famiglia aveva in affitto nella zona del Battilanino e nessuno, tranne mia nonna, era al corrente dell'aiuto che diede a quelle persone in tempo di guerra, neanche mia madre e le mie zie.
A mia nonna si era raccomandato di non palarne con nessuno, perché i fascisti c'erano ancora, erano risaputamente vendicativi e non si poteva mai sapere come sarebbe andata la politica in futuro. Soltanto dopo la sua morte, mia nonna si decise a parlarne con il resto della famiglia. In verità mia madre e mia zia sua gemella, qualcosa avevano già sospettato prima che la guerra terminasse, allorché furono fermate dai nazifascisti a Canevara, dove si erano recate per scambiare prodotti, e condotte in caserma per essere interrogate sui comportamenti del loro padre.
Avevano, a quel tempo 23 anni, e in caserma furono costrette, impaurite e piangenti, a trascorrere la notte. Le rilasciarono il mattino successivo, dopo il diavolo a quattro che fece là dentro mia nonna, che, preoccupata per il loro mancato rientro e avvertita della cosa da conoscenti, era scesa anch'essa a Canevara. Esse sospettarono ma, per paura, mai fecero ai genitori domande sull'argomento, ben consce che, in quei casi, era molto meglio per tutti non sapere nulla.
Da parte mia, nel 1955, mi presi la pertosse, allora meglio conosciuta come "tosse cattiva", e, per facilitarne la guarigione (così si pensava allora) il dottore si raccomandò di portarmi a respirare aria di montagna.
In quel periodo, mio padre, dopo aver fatto la guerra in marina, si era imbarcato su una petroliera e mandava a casa praticamente tutto quello che guadagnava, per acquistare un piccolo terreno e costruirci su la nostra futura casa. Mia madre dava il suo contributo andando a servizio presso famiglie facoltose e facendo da manovale ai due muratori, che poi erano mio nonno paterno e il mio futuro zio acquisito, colui che avrebbe poi sposato la minore delle mie zie. Quest'ultima che, avendo "soltanto" 14 anni più di me, io consideravo più come una inseparabile sorella maggiore, fu colei che poi mi accompagnò sempre ad Antona.
In tale situazione, è ben capibile che di soldi da spendere in altro ne restavano ben pochi, per cui di andare in alta montagna non se ne parlò neppure e si pensò ad Antona e ai parenti che avevamo lassù. Non sarebbe stata montagna vera e propria, ma sempre meglio che stare al mare, era.
Arrivammo in paese, mia zia ed io, che era da poco passata la metà di giugno. Conobbi tutti i parenti e, pian piano, praticamente tutti gli abitanti, e loro conobbero me, tanto che, nel giro di quell'estate, divenni praticamente uno di loro.
La pertosse poi passò, ma io, da allora, tornai lassù a trascorrere un mesetto di vacanza per diverse estati ancora.
Ci tornavo volentieri. Per i giochi non c'erano problemi, avevo fatto amicizia con i miei coetanei del posto e per il resto, beh... per il resto, ogni famiglia di lassù aveva in casa una cassapanca piena zeppa di una farina di castagne dolcissima, talmente pressata che si doveva tagliare a blocchi con il coltello e c'era un piccolo forno dal quale, al mattino, usciva un profumo di pane cotto a legna che stordiva e che, infiltrandosi nei vicoli, invadeva tutto il paese entrando in ogni casa. E da quel forno usciva una sorta di focaccina schiacciata alla quale non sapevo resistere. La chiamavano "pastella".
E io di pastella, della farina di castagne di Antona e dei suoi derivati, fossero essi castagnacci, torte o frittelle, magari con ricotta dei pochi pastori locali ancora rimasti nei dintorni, non ero mai sazio.
Mi affezionai subito a quei parenti, soprattutto a uno di loro, che qui chiamerò con il nome fittizio di Carlo, o meglio ancora con il suo diminutivo, Carlin, visto che con il diminutivo dialettale eravamo tutti soliti chiamare anche il personaggio vero e proprio.
Carlin era uno che non poteva stare fermo, doveva per forza fare sempre qualcosa. Aveva diversi orti terrazzati a cui accudire e diversi animali da cortile e conigli. Aveva anche un paio di caprette con le quali ero solito divertimi. Fu lui a portarmi al "caniccio" (o "canniccio"), come si soleva chiamare da quelle parti il metato, l'essiccatoio delle castagne, e a mostrarmene il funzionamento. Ne rimasi stregato.
Mi raccontava anche tante balle, anche se me ne resi conto soltanto crescendo. Quella che più mi è rimasta impressa riguarda un paio di granchi.
![[...]mi accorsi, con mia grande sorpresa, che sui sassi del bordo c'erano due granchi[...] Granchi](PaesiApuaniIMG/Granchi.png) Un giorno mi propose di accompagnarlo in uno dei suoi orti, in Campareccia, ed io acconsentii ben volentieri, sapendo che, di certo, non mi sarei annoiato.
Un giorno mi propose di accompagnarlo in uno dei suoi orti, in Campareccia, ed io acconsentii ben volentieri, sapendo che, di certo, non mi sarei annoiato.
Camminando lungo il sentiero, arrivammo ad un ruscelletto che lo attraversava. Quel piccolo corso d'acqua, in quel punto, appariva come una cascatella alta circa un metro che aveva formato nella parte a monte del sentiero, una piccola pozza di acqua limpidissima, grande poco più di un catinella, e poi ne usciva riprendendo a scendere a valle, attraversando il tracciato.
Ci fermammo a bere, raccogliendo con le palme delle mani l'acqua della cascatella ed io, chinando il capo e rivolgendo lo sguardo al minuscolo laghetto, mi accorsi, con mia grande sorpresa, che sui sassi del bordo c'erano due granchi.
Rimasi sbalordito. Ero fermamente convinto che i granchi fossero esclusivamente animali marini, che ci facevano in montagna?
Guardai Carlin. Di certo dovevo portare quell'immenso stupore stampato in faccia, visto che lui si mise a ridere e mi chiese cosa avessi.
A questo punto mi sento in dovere di precisare che Carlin era anche una persona che parlava alla perfezione due lingue: il dialetto massese e il dialetto carrarino e, essendo perfettamente conscio di non saper fare altrettanto con l'italiano, a me si rivolgeva in carrarino puro.
"S'pin, ma cos't'a? A'l par che t'a vist un linchet'!" (S'pin, ma cos'hai? Sembra che tu abbia visto un Linchetto!)
S'pin (con la S dolce) era il nomignolo, diminutivo dialettale, con il quale mi chiamava mio nonno buonanima e Carlin l'aveva subito preso in eredità.
"Carlin, ma quelli lì sono granchi, non li vedi?"
"E scì, i en granchi. E adora?" (Sì, sono granchi. E allora?)
"Ma come allora? E cosa ci fanno qui?"
A quel punto a Carlin non ci volle molto a capire cosa avevo pensato.
"Ma scus un po', o belo, ma cos't't'cred te? Che su p'r i monti t'i pò v'nir che te? I's saran stufati d'star al mar 'n mez al casino e i en v'nuti chi p'r star un pò'n pace. Cos't'i trov d' cuscì stran?" (Ma scusa un po', ragazzino, cosa pensi? Che qui sui monti ci puoi venire soltanto tu? Si saranno stancati di stare al mare, in mezzo alla confusione, e sono venuti qui per stare un po' in pace. Cosa ci trovi di così strano?)
"E come ci sono arrivati fin qui?" chiesi ancora incredulo.
"Ma i'n't'lan 'nsignat a te che l'aqua a'l va al mar?" (Ma non te l'hanno insegnato che l'acqua va al mare?)
"Sì che lo so che l'acqua va al mare!"
"E adora t'saprà c'a'i va anc st'aqua chi, no?" (E allora saprai che ci va anche quest'acqua qui, no?)
"E allora?"
"Ma com e adora... se st'aqua chi a'l va al mar, lor dal mar i poss'n arivar n'fin'a chi, basta chi van contr' a la corente. A'n t par?" (Ma come 'e allora'... se quest'acqua qui va al mare, loro dal mare possono arrivare fin qui, basta che vadano contro la corrente. Non ti sembra?)
"Vuoi dire che hanno risalito tutto il ruscello, dal mare fino a qui?"
"E se no, com t'la spieg te, 'sta magagna..." (E altrimenti come la spieghi tu questa strana storia...)
Per tutto il rimanente tragitto non pensai ad altro, cercando di immaginare le difficoltà che avevano superato quei due granchi per arrivare dal mare fin dove li avevo visti e quanto tempo ci avessero impiegato. Di certo è che credetti a quella spiegazione fin quando, ben più grande, scoprii che esistevano anche i granchi d'acqua dolce, ma, a quei tempi, convinsi a credere a quella storiella anche un mio cugino che aveva iniziato a venire ad Antona con me.
![[...]sembrava un gomitolo di lana pelosa rossa dalla quale uscivano due gambette minute e due piccole braccia striminzite bianche e rosse[...] Bafardel](PaesiApuaniIMG/Bafardel.png) I momenti più belli, quelli che ricordo più volentieri, sono quelli però del periodo autunnale, quando i miei mi portavano su durante il ponte dei Santi, ad inizio novembre. In quel periodo i canicci erano accesi e per me il fumo, il calore e l'odore che quello di Carlin emanava, lassù nel bosco di castagni, mi inebriava al pari di un magico filtro. La sera, poi ci si adunava davanti al camino acceso e Carlin partiva con i suoi racconti. E cosa ci poteva essere di meglio, per un bambino, di racconti che parlano dei boschi e dei suoi magici abitanti?
I momenti più belli, quelli che ricordo più volentieri, sono quelli però del periodo autunnale, quando i miei mi portavano su durante il ponte dei Santi, ad inizio novembre. In quel periodo i canicci erano accesi e per me il fumo, il calore e l'odore che quello di Carlin emanava, lassù nel bosco di castagni, mi inebriava al pari di un magico filtro. La sera, poi ci si adunava davanti al camino acceso e Carlin partiva con i suoi racconti. E cosa ci poteva essere di meglio, per un bambino, di racconti che parlano dei boschi e dei suoi magici abitanti?
Il giorno dei granchi, leggendo lo stupore sulla mia faccia, Carlin mi aveva chiesto se avevo visto un linchet' e, alla mia domanda di cosa fosse, egli mi diede una risposta vaga, superficiale, rimandando a poi una spiegazione più approfondita. E quella spiegazione, insieme ad altre, mi furono date proprio durante quelle mie brevi visite autunnali.
"'L linchet? 'L linchet i è tanti lavori. I'l chiam'n cuscì da la parta d'là, da la parta d'Arni, quela luchesa. Chì, noaltri, a'l chiaman Bafardel. A'i è chi i'l'a vist come un omet alt mez metr, dal mus cativ e con la barba, chì 'nvecia com un ninin ch'i's podev t'nir sul palm d'una man, altri, anca mò, ch'i parev un gumit'l d'lana p'losa rossa, d'n dov a'l surtiv'n dò gambette m'nute e dò bracin str'm'ziti a strisce bianch'e rosse. Tuti però i diz'n ch'i avev sempr un cap'din ross a punta su'n't'la testa e ch'i's movev svelt pù d'un gat. Ma a'lè mej non v'derl, c'l bastardel lì, p'rché pò, se t'i sta su'n t'le bale, te'n t camp pù, lu i't'n fa d'tuti i colori. I spavent i tò animali e i'li fa scapar chissà 'n'dov, i's'asset su 'n t'la to pancia quand t'dorm e i'n't fa pù r'spirar, e sempr' quand t'sen adurmit, i't'agrup tutti i capedi, tant che te 'n t'li po pù p't'nar e a t'toc p'lart la testa a ov d'gadina. E pò tanti altri bruti lavori c'a'n't stag a dir..." (Il Linchetto? Il Linchetto è tante cose. Lo chiamano così dall'altra parte, dalla parte di Arni, quella lucchese. Qui noi lo chiamiamo Bafardel. C'è chi l'ha visto sottoforma di un omino alto mezzo metro, dalla faccia cattiva e con la barba, chi invece come un bambino che si poteva tenere sul palmo di una mano, altri ancora che sembrava un gomitolo di lana pelosa rossa dalla quale uscivano due gambette minute e due piccole braccia striminzite bianche e rosse. Tutti però dicono che portava sempre un cappello a punta e che si muoveva più svelto di un gatto. Ma è meglio non vederlo quel bastardello lì, perché poi, se gli stai antipatico, non vivi più, te ne fa di tutti i colori. Lui spaventa i tuoi animali, li fa scappare chissà dove, si siede sulla tua pancia quando dormi e non ti fa più respirare, e, sempre di notte, ti annoda tutti i capelli, tanto da non poterli più pettinare, cosicché ti tocca farti rapare la testa tipo uovo di gallina. E poi tante altre brutte cose che non ti sto a dire...)
![[...]chi invece come un bambino che si poteva tenere sul palmo di una mano[...] Bafardel giovane](PaesiApuaniIMG/Bafardel2.png) Ricordo bene che mia zia, sempre molto protettiva nei miei confronti, in quell'occasione invitò Carlin e non raccontarmi più quelle storie, perché avrei potuto impressionarmi. E invitò pure me a non dargli retta, perché quei racconti erano tutte scemenze. Però il mattino successivo, quando mi impose di mettere i calzini a rovescio, non volle darmi nessuna spiegazione in proposito. La cosa che so è che i calzini potei rimettermeli nel modo giusto soltanto dopo che fui tornato a casa mia.
Ricordo bene che mia zia, sempre molto protettiva nei miei confronti, in quell'occasione invitò Carlin e non raccontarmi più quelle storie, perché avrei potuto impressionarmi. E invitò pure me a non dargli retta, perché quei racconti erano tutte scemenze. Però il mattino successivo, quando mi impose di mettere i calzini a rovescio, non volle darmi nessuna spiegazione in proposito. La cosa che so è che i calzini potei rimettermeli nel modo giusto soltanto dopo che fui tornato a casa mia.
Comunque Carlin uno di quegli "altri bruti lavori" a cui accennò, dietro mia insistenza, me lo raccontò lo stesso.
Un suo amico pastore, Francé, aveva un cane che si chiamava Fulgenzio. Questo cane era il miglior guardiano di greggi che c'era sulle Apuane, ligio al dovere e pronto a scattare ad ogni ordine che gli veniva dato dal padrone. Era talmente ben addestrato che avrebbe potuto condurre al pascolo le capre e riportarle al caprile da solo, senza alcun problema.
Una notte di luna piena il pastore fu svegliato dal suo continuo abbaio allarmato. Si alzò pertanto a vedere cosa stava accadendo, e, arrivato al caprile con la lampada ad acetilene in mano, vide il Bafardel che, attaccato alle mammelle di una capra, stava succhiandole tutto il suo latte. Prese allora, da un grosso barattolo che teneva vicino all'ingresso, un buon pugno di quel sale che usava per le sue bestie, e lo tirò contro il folletto che, subito, si diede alla fuga, lanciando urla incomprensibili ma chiaramente minacciose.
Sapendo che sarebbe tornato nelle notti successive, il pastore mise poi nel caprile diversi rami di sambuco, in modo che il Bafardel (che, evidentemente e chissà per quale motivo, il sambuco non lo sopporta) non potesse entrare di nuovo. Per due notti non successe nulla ma, al mattino successivo alla terza notte, grande fu il suo stupore quando, uscito si casa, vide il suo cane nell'aia con la coda annodata.
Il Bafardel non era più riuscito ad entrare nel caprile a rimpinzarsi di latte ma si era vendicato. Evidentemente aveva ritenuto il cane, che aveva dato l'allarme, responsabile di tutto e l'aveva punito in quel modo. Il pastore fu costretto a chiamare un veterinario, al quale non restò altro da fare che tagliare la coda al povero cane, lasciandogliene solo un mozzicone.
Devo dire che quel racconto mi lasciò parecchi dubbi. Avendo un cane anch'io, sapevo benissimo che la loro coda non si può annodare, ma il giorno successivo, il 2 di Novembre, andando al cimitero con mia zia e un amico del luogo, ci imbattemmo in un vecchio che quel nostro amico salutò chiamandolo Francé. Ebbene, quel vecchio era seguito da un grosso cane pastore con la coda mozzata.
![[...]e, arrivato al caprile con la lampada ad acetilene in mano, vide il Bafardel che[...] Bafardel giovane](PaesiApuaniIMG/Bafardel3.png) Io di cani con la coda mozzata ne avevo già visti diversi, ma erano tutti cani da caccia, sapevo che i cacciatori usavano far tagliare le loro code quando essi erano ancora piccolissimi, ma mai ne avevo visto in quelle condizioni uno che fosse da pastore. Alla mia richiesta di spiegazioni, l'amico mi rispose dicendomi che quel povero animale si chiamava Fulgenzio e che, fino a poco tempo prima, aveva una bellissima coda ma poi... e mi raccontò la storia tale e quale a come me l'aveva raccontata Carlin.
Io di cani con la coda mozzata ne avevo già visti diversi, ma erano tutti cani da caccia, sapevo che i cacciatori usavano far tagliare le loro code quando essi erano ancora piccolissimi, ma mai ne avevo visto in quelle condizioni uno che fosse da pastore. Alla mia richiesta di spiegazioni, l'amico mi rispose dicendomi che quel povero animale si chiamava Fulgenzio e che, fino a poco tempo prima, aveva una bellissima coda ma poi... e mi raccontò la storia tale e quale a come me l'aveva raccontata Carlin.
Di fronte a tale conferma, mi convinsi così che Carlin non mi aveva raccontato una panzana e che noi umani non saremmo mai riusciti a fare un nodo alla coda di un cane, ma il Bafardel, un essere magico che in fatto di nodi era risaputamente espertissimo, evidentemente ci riusciva. Eccome se ci riusciva!
Ma nei boschi non esisteva soltanto il Bafardel. Mi fu spiegato che c'erano anche fate, streghe, streghi e folletti di altro tipo, che vivevano in comunità, non solitari come il Bafardel.
E, proprio ad un evento riguardante questi ultimi, fui proprio io di persona ad esserne partecipe.
Un giorno Carlin tornò dall'orto agitatissimo ma non voleva raccontare a nessuno cosa gli era successo. Rimasto solo con lui, riuscii, dopo non poche insistenze, a farmi dire qual'era la causa di quel suo stato d'animo.
Egli si era levato di buon mattino per andare a zappare l'orto della vigna, da lui lo così definito in quanto, a suo tempo, aveva provato, con scarso successo, a piantarvi alcuni filari di viti. Quando era arrivato sul posto aveva sentito dei rumori provenire dall'interno della casetta, quella che lui chiamava "la cantinetta", dove teneva ammucchiata in malo modo, quell'attrezzatura che si era precedentemente procurata nella troppo ottimistica previsione di future buone vendemmie. Essa era composta da due vani, quello dove c'era l'entrata e che avrebbe dovuto anche fungere da cucina, visto che era dotata di un tavolo, due sedie e un fornello con bombola di gas, e l'altro che fungeva da ripostiglio, anche se tutti gli oggetti che avrebbe dovuto contenere, stavano, presumo per comodità d'uso perché più a portata di mano per chi entrava ed usciva, ammassati invece nella cucina.
Comunque sia, alquanto allarmato, Carlin era entrato e si era guardato intorno. All'inizio tutto taceva e lui iniziò a pensare di essersi sbagliato, ma quando spalancò la finestra i rumori iniziarono di nuovo, dapprima tenui, poi sempre più forti, sempre più forti... spaventato, si girò verso la porta per uscire, ma non ci riuscì. Veloci come gatti, dei folletti alti un palmo di mano, gli si pararono davanti, gli girarono intorno strillando e facendogli versacci e sberleffi e poi sparirono.
Disse di averne contati tre e che, di certo, si erano nascosti al buio, dietro a tutti quegli attrezzi per non farsi vedere ma che, quando aveva aperto la porta e la finestra facendo entrare la luce, quelli si erano agitati ed erano fuggiti.
Ed era proprio il loro numero quello che lo preoccupava.
Mi disse che era risaputo che in quei boschi abitavano folletti, lo sapevano tutti i contadini e i boscaioli, e che se li vedevi in giro non succedeva nulla, ma se te li ritrovavi in casa o in cantina, allora la cosa cambiava. Esisteva infatti una sorta di codice, di loro legge che si poteva riassumere in questo modo:
![[...]c'erano anche fate, streghe, streghi e folletti di altro tipo, che vivevano in comunità[...] Folletti](PaesiApuaniIMG/Folletti1.png) 0 = Rispet' (Rispetto), 1 = Sospet' (Sospetto), 2 = Dispet' (Dispetto), 3 = Maladet' (Maledetto)
0 = Rispet' (Rispetto), 1 = Sospet' (Sospetto), 2 = Dispet' (Dispetto), 3 = Maladet' (Maledetto)
ovvero finché li vedevi in giro ma non in casa tua (0) significava che avevi il loro rispetto, se ne vedevi uno (1) in casa significava che da parte loro c'era un sospetto, ovvero che tu avevi fatto loro, avvertitamente o inavvertitamente, qualcosa per la quale eri sotto giudizio, se ne trovavi due (2) era dispetto, ovvero la cosa non era stata giudicata grave e saresti stato oggetto quindi soltanto di dispetti, ma se la visita era di tre folletti (3), beh, allora c'era da preoccuparsi, perché eri stato giudicato maledetto e le conseguenze sarebbero state gravi. L'ultimo contadino che così era stato giudicato, si era ritrovato con il fienile completamente distrutto da un incendio.
Carlin a quel punto era disperato, convinto che sua cantinetta avesse le ore contate. Io cercavo di tirarlo su, dicendogli che forse avremmo potuto trovare un accordo dando qualcosa ai folletti, ma lui mi rispose che non c'era nulla da fare, che non aveva nulla di così importante da poter fare cambiar loro idea... poi gli venne in mente qualcosa, un particolare di quella visita. Quando i folletti, prima di andarsene, lo avevano sbeffeggiato, ne aveva visto uno senza cappello! Sì, lo ricordava benissimo, ce n'era proprio uno senza cappello! E di certo doveva averlo perso nella cantinetta, quando si era nascosto, perché i folletti non vanno mai in giro senza il loro copricapo che è ciò che li fa diventare invisibili, più grandi o più piccoli a loro piacimento! Dovevamo cercare immediatamente quel cappello.
Ricordo che io non capivo. Che ci avremmo dovuto fare noi con il cappello di un folletto?
Carlin mi spiegò così che ciascun folletto poteva fabbricarsi soltanto un cappello e non di più. Per costruirlo egli segue una formula magica, che impone di usare determinati materiali tra i quali figura anche la buccia delle patate. Quei cappelli, grazie a quella formula, nulla e nessuno può distruggerli. Nulla e nessuno tranne un piccolo animaletto, un insetto insignificante, ma golosissimo di patate che, attratto dall'odore della buccia di quel tubero, poteva divorarli in quattro e quattr'otto insieme al loro potere magico.
Il goloso animaletto era la "bubanicia" (il grillotalpa) e il folletto che era rimasto a testa scoperta, in quel momento, era di certo disperato perlomeno quanto Carlin, visto che se non rientrava in possesso del suo copricapo, praticamente non sarebbe più stato nemmeno un folletto.
Ma noi dovevamo sbrigarci, dovevamo fare tutto prima del tramonto, perché con l'oscurità, i folletti sarebbero di certo tornati a riprendere il cappello perduto.
![[...]dei folletti alti un palmo di mano, gli si pararono davanti, gli girarono intorno strillando e facendogli versacci e sberleffi [...] Tre Folletti](PaesiApuaniIMG/TreFolletti.png) Ci dividemmo i compiti. Carlin a zappare l'orto per trovare la bubanicia ed io a cercare il cappello in quel marasma di bigonci, botticelli e damigiane. Non era facile districarsi in mezzo a tutta quella roba, toglievo una damigiana e cadeva un bigoncio, toglievo il bigoncio e cadeva una botticella rischiando di rompere fiaschi e bottiglie, così decisi di spostare, uno ad uno, ogni oggetto dalla cucina al ripostiglio. Fu faticoso ma, alla fine, a sgombero pressoché terminato, trovai il cappellino. Era rosso, grande più o meno quanto un limone e pareva in pelle o in cartapecora. Lo mostrai trionfante a Carlin e lui, dall'orto, mi rispose sorridente, sollevando in alto una mano: teneva tra le dita una bella bubanicia! Ce l'avevamo fatta.
Ci dividemmo i compiti. Carlin a zappare l'orto per trovare la bubanicia ed io a cercare il cappello in quel marasma di bigonci, botticelli e damigiane. Non era facile districarsi in mezzo a tutta quella roba, toglievo una damigiana e cadeva un bigoncio, toglievo il bigoncio e cadeva una botticella rischiando di rompere fiaschi e bottiglie, così decisi di spostare, uno ad uno, ogni oggetto dalla cucina al ripostiglio. Fu faticoso ma, alla fine, a sgombero pressoché terminato, trovai il cappellino. Era rosso, grande più o meno quanto un limone e pareva in pelle o in cartapecora. Lo mostrai trionfante a Carlin e lui, dall'orto, mi rispose sorridente, sollevando in alto una mano: teneva tra le dita una bella bubanicia! Ce l'avevamo fatta.
Mettemmo il cappellino dentro una scatola da scarpe senza coperchio, insieme ad un vasetto per la marmellata, chiuso da una tavoletta di legno, in cui avevamo riposto la bubanicia. Insieme ad essi Carlin mise nella scatola da scarpe anche tre more di rovo, quindi ce ne andammo a casa.
Il pomeriggio del giorno successivo Carlin venne a prendermi per andare a vedere cos'era successo. Nella scatola erano rimasti soltanto il vasetto vuoto e la tavoletta che lo ricopriva. Nient'altro.
Carlin tirò un sospiro di sollievo, mi diede una sberletta in testa e mi spiegò. Le tre more le aveva messe per sapere, secondo il loro codice, cosa avevano deciso i folletti dopo che avevamo restituito loro il prezioso cappello, da noi salvato dal letale appetito di una feroce bubanicia.
Ed essi avevano risposto prendendo tutte e tre le more, non lasciandone neppure una, quindi zero. Zero che, come sapevamo, secondo il loro codice, stava a significare "Rispetto".
Tutto si era concluso nel migliore dei modi.
A quel tempo avevo sei anni e, ovviamente, soltanto diverso tempo dopo capii che Carlin aveva messo in piedi tutta quella sceneggiata per far sì che qualcun altro gli mettesse un po'in ordine la cantinetta mentre lui zappava l'orto. Ma voleva che quel qualcun altro (cioè io) lo facesse volentieri, divertendosi e divertendo anche lui stesso... ma quel cappellino rosso incartapecorito? Fu proprio lui a spiegarmi, ridendoci ancora sopra diversi anni dopo, che era quello di un ricordo, di un Pinocchio in legno comprato in occasione di una gita a Collodi e da lui fatto cadere a bella posta nell'angolo più nascosto, dietro a tutte quelle cianfrusaglie, in modo che io avessi potuto trovarlo soltanto dopo averne spostato la maggior parte possibile.
![[...]Il goloso animaletto era la bubanicia (il grillotalpa)[...] Grillotalpa](PaesiApuaniIMG/grillotalpa.png)
Non so se si usi ancora fare racconti di questo tipo nei paesini delle Apuane nè se esistano ancora usanze sull'argomento, i tempi sono cambiati e con essi sono cambiate le persone, il loro modo di vivere e quello di rapportarsi con figli e nipoti. So soltanto che io mi ritengo fortunato a essere nato in quel lontano periodo e ad aver vissuto quel tipo di infanzia, un'infanzia semplicissima ma che è stata pur sempre una bella esperienza e anche una lezione di vita, una lezione non imposta ma appresa liberamente più che volentieri, nel segno del divertimento e della spensieratezza.
E continuo a pensare che questa sia ancor oggi una cosa da tenere sempre presente. I bambini hanno bisogno di crescere e di fare le loro prime esperienze nel modo a loro più congeniale, quel modo che consente loro di apprendere con il minor sforzo possibile, ovvero divertendosi e vivendo i propri fantastici sogni, perché ogni fase della nostra vita, della nostra crescita ha delle esigenze diverse che non andrebbero mai trascurate. Io, grazie al piccolo paese di Antona, una buona parte di quei sogni di infanzia li ho vissuti e, se alla mia veneranda età ne ho sempre un ricordo così vivo e piacevole, qualcosa vorrà pur dire.